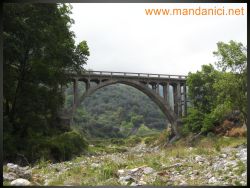 L'Abate Paolo Balsamo nel suo
giornale di viaggio fatto in Sicilia nel 1808 scriveva “non esservi ai suoi
tempi in Sicilia un palmo di comunicazione fra l'una e l'altra terra: divise
le popolazioni, sconoscevansi; i proprietari lontani sempre dai loro fondi e
quelli medesimi che avrebbero voluto visitarli ne rimanevano spaventati per
gli immensi disagi e dispendi ai quali si esponevano. Né alberi dunque né
uomini, né vita alcuna vedevasi nella terra del sole; le produzioni
languivano,incolti rimanevano i campi.”
L'Abate Paolo Balsamo nel suo
giornale di viaggio fatto in Sicilia nel 1808 scriveva “non esservi ai suoi
tempi in Sicilia un palmo di comunicazione fra l'una e l'altra terra: divise
le popolazioni, sconoscevansi; i proprietari lontani sempre dai loro fondi e
quelli medesimi che avrebbero voluto visitarli ne rimanevano spaventati per
gli immensi disagi e dispendi ai quali si esponevano. Né alberi dunque né
uomini, né vita alcuna vedevasi nella terra del sole; le produzioni
languivano,incolti rimanevano i campi.”
Per Goethe il territorio siciliano
presentava “singolari deserti di fecondità”.
Mi è venuto in mente di ricercare e
di riportare queste brevi notizie sulle vie di comunicazioni del nostro
paese perché nel breve volgere di un secolo sono state rinnovate e molte di
esse sono scomparse, per cui non ci sarà più né la memoria orale né
l'utilizzo quotidiano delle stesse come è avvenuto per i secoli passati. Pur
mancandoci le informazioni scritte né essendo semplice ricostruire i
tracciati, in quanto sepolti dalla fitta macchia mediterranea e ormai
abbandonati nel loro utilizzo, siamo in grado di registrare le notizie orali
di gente che in tempi passati li hanno percorsi per lavoro o per andare a
caccia senza l'utilizzo di ipotesi strampalate e gratuite.
Una considerazione veloce,a primo
acchito, che si può trarre sulle nostre vie di comunicazioni è che nulla a
tutt'oggi da allora è cambiato,anzi.
Difficili, quasi impossibili erano
gli impervi sentieri che ci collegavano con i confinanti paesi di
montagna,quasi da incubo raggiungere la marina attraverso il torrente
Dinarini specie nel periodo invernale. Eravamo in presenza di piste che
battute giornalmente dagli uomini e dagli animali avevano rappresentato per
millenni le principali vie di comunicazione di questo angusto territorio
soffocato all'interno di montagne ripide e ingenerose.
Queste mulattiere preistoriche
demaniali di notevole interesse ambientale e paesaggistico pur non essendo
state programmate e progettate si sono realizzate giorno dopo giorno,anno
dopo anno,secolo dopo secolo, e si sono radicate sul territorio diventandone
parte infrastrutturale integrante del territorio. I tracciati principali
s'intrecciavano capillarmente come reticoli venosi con altri viottoli più
stretti e più scoscesi che molto spesso attraversavano e servivano le
proprietà private.
Oggi polverose e pericolose strade
sterrate ci collegano con i paesi di montagna, mentre una provinciale che
certamente non può considerarsi tale ci conduce a Roccalumera.
Non si vuole capire, da chi ne ha
l'obbligo, il concetto molto semplice che è la strada che deve raggiungere i
paesi e non viceversa. Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo spostarci
tutti alla marina di Roccalumera come in questi ultimi decenni si sta
verificando. Il paese deve restare, la gente deve restare,è la strada, degna
di questo nome, che deve arrivare. Le nuove tecniche di costruzione
acquisite dall'ingegno umano sono in grado di superare le oggettive
difficoltà naturali di un territorio come il nostro abbastanza ingeneroso
nei confronti dei suoi abitanti. Solo una veloce strada di collegamento può
togliere Mandanici dal grave disagio economico e sociale nel quale politiche
egoistiche e poco lungimiranti hanno deciso di relegarlo e la forte
emorragica contrazione demografica degli ultimi decenni ne è la prova
provata con il ripopolamento delle aree urbane a scapito di quelle rurali.
La viabilità è stata da sempre la nota dolente per la già fragile economia
agricola del nostro territorio impedendo di fatto rapporti commerciali e
relazioni sociali con la marina che si avviava verso una piena fase di
sviluppo grazie alla costruzione della strada statale Messina-Giardini e
della linea ferroviaria. Per assurdo, ma non tanto, se la statale fosse
stata costruita alcuni chilometri più a monte,tra Rocchenere e Pagliara, non
solo i paesi marinari, potendo utilizzare meglio il loro territorio in atto
limitato dall'autostrada e dalla linea ferrata, avrebbero avuto maggiori
vantaggi per una migliore espansione urbanistica e produttiva ma anche i
paesi di montagna avrebbero avuto significative opportunità di sviluppo. Si
potrebbe ovviare agli errori passati con la strada intervalliva da tutti
ideata e progettata ma da nessuno realizzata. Le vie di comunicazione da
sempre sono state d'impulso per la propagazione del benessere e per la
pacifica convivenza,senza di esse il territorio può essere abbandonato al
pascolo,al bosco e al fuoco con le inevitabili ripercussioni sul dissesto
idrogeologico le cui conseguenze finali vanno a scaricarsi sulla marina con
un costo enorme per la collettività.
Mandanici per la sua difficoltà di
accesso nei secoli passati si è trovato in una posizione geografica ottimale
per quanto riguardava la sua sicurezza e per la sua economia agricola
quand'anche di semplice sussistenza. La stessa cosa non può dirsi dell' ieri
e dell'oggi trovandosi in un non voluto isolamento fuori dalle realtà
politiche ed economiche dell'intero comprensorio e il tutto per la mancanza
di idonee vie di comunicazione.
Le nostre antiche “vie di
comunicazioni” del 1800 e prima si sviluppavano su quattro direttrici
costituendo una prima maglia infrastrutturale dell'intero territorio: A sud:
per Misserio-Savoca, a sud est: per Pagliara-Roccalumera,a nord-est: per
Fiumedinisi, a nord ovest: per Castroreale
Per andare a Misserio e Savoca:
L'Itinerario che i nostri antenati
utilizzavano per recarsi nel vicino paese di Misserio era per certi versi
breve e veloce,attraversava sia terreni incolti sia terreni abilmente
terrazzati e coltivati a grano prima e ad uliveto poi. Le contrade
attraversate, i cui toponimi resistono ancora coerenti con il tempo che
scorre,erano fortemente antropizzate e dotate di piccole costruzioni con
muri a secco (caseddi) per ripararsi nel caso di improvvisi temporali e dal
freddo intenso nei momenti di riposo. Questo descritto era l'itinerario più
veloce e più praticato per chi voleva andare a Misserio e viceversa.
Certamente tantissimi altri violi consentivano di arrivarci,se per
esempio ci si trovava nella contrada puttedda o sella di Nicufoliu non si
andava a Furisteri ma si scendeva direttamente nell'altro versante e si
arrivava ad Artale e da lì poi si proseguiva per Misserio. Partendo da
questi presupposti e da Mandanici si attraversava il torrente Dinarini,
quando non era in piena, con tutti i rischi connessi nel periodo invernale
essendo sprovvisto di adeguati ponti,e si arrivava al vallone di contrada
Ciontina,contrada posta nel dirimpettaio territorio di Pagliara, proprio
vicino a Palmolia piccolo borgo antico dipendente da Savoca,detto” porta di
Mandanice”dai mandanicesi,”porta di Parmolio” dai savocesi. Palmolia oggi è
un insieme di ruderi di poche casupole interrate dalle frequenti alluvioni
nel XIX° secolo posto davanti al quartiere Pantano di Mandanici sull'argine
destro del Dinarini. Da Ciontina si saliva per circa centocinquanta metri
percorrendo un' antica mulattiera demaniale, si girava poi verso est per la
contrada “a Luvaredda “(di fronte al quartiere Spafaro in Mandanici) per
attraversare poi con leggere pendenze, andando sempre ad est (direzione
Locadi), la contrada Canale. In questa contrada una biforcazione consentiva:
la prima di continuare per Calarù e poi per sopra Locadi, con la seconda con
ripide rampe a gomito che si accartocciavano su se stesse si ascendeva fino
ad oltrepassare il crinale nel suo punto più basso la contrada puttedda di
Furisteri posta sul punto cacuminale dei due versanti. Da questo crinale si
scendeva per la contrada Massa Valanca e poi ancora giù fino alla base della
montagna e si arrivava così nella contrada denominata vadduni funnaci
(vallone fornace), si attraversava il torrente e si era giunti a Misserio.
Il tempo necessario per percorrere questo tragitto era soggettivo ma
indicativamente per gente con buone gambe e buoni polmoni era di circa 80
minuti, uno o due pusaturi consentivano a chi portava dei pesi di
riprendere fiato.
Questi impervi sentieri dalla
larghezza di circa due metri , per consentire il passaggio di animali con
cofina, e con pendenze in alcuni tratti superiori al 40% sono stati
utilizzati indistintamente dai Mandanicesi e dai Missarioti per la raccolta
delle olive, per la mietitura del grano,del fieno e per la partecipazione a
cerimonie religiose. Ogni anno, la seconda domenica di agosto, si utilizzava
questo percorso per la ricorrenza della festa di Santa Lucia a Savoca o per
le fiere del SS.Salvatore e di San Michele a Mandanici. Le strade carrabili
interpoderali in terra battuta realizzate nell'ultimo ventennio del secolo
appena passato che attraversano in lungo e largo le campagne della zona ne
hanno snaturato il vecchio tracciato rendendolo invisibile e abbandonato in
modo definitivo il suo utilizzo. La mancanza di interventi adeguati per il
convogliamento delle acque meteoriche le rende franose e insicure.
Per andare a Fiumedinisi:
Per recarsi a Fiumedinisi la strada
era molto più lunga rispetto a quella per Misserio tanto che il tempo
necessario quasi raddoppiava, ma nonostante ciò molti vi si recavano per i
modesti scambi commerciali e molti matrimoni si sono realizzati tra i
giovani componenti delle due comunità. Si partiva dal quartiere Rocca e in
salita si raggiungeva contrada Cabbariu (Calvario), da lì si arrivava alla
contrada Scalunazzu e quindi o “gghianu cannarozzu“ e poi “o serru di
Muddirinu” ( Mollerino). Si raggiungeva poi Acqua Pirara. Qui era (ed è)
d'obbligo riposarsi,bere la buona acqua presente ( la migliore di tutto il
territorio) e poi pronti per inerpicarsi fino ad arrivare a “puttedda riti”
(portella riti) da dove percorrendo un lungo viottolo quasi pianeggiante
verso sud-est si perviene al confine ( posto all'acqua pendente) con
Fiumedinisi nella parte a monte e più precisamente a “puttedda Palumma” (portella
palumma).Scendendo adesso ci incontra il pianoro di Brunnu ricco di gelsi
neri, e se la stagione è quella giusta si può fare il pieno e proseguire
verso la contrada Cciappa, ove sono presenti alcuni ruderi, e poi per
Licàntru. Siamo quasi giunti “ e du ciumari (alle due fiumare) e non ci
resta che Puttedda Pidària, la contrada San Pantaleo e siamo “a Santissima”
una zona d'incomparabile bellezza paesaggistica,ed eccoci stanchi morti a
Fiumedinisi. Ne valeva la pena, una bella scarpinata che ancora oggi è
possibile effettuare in quanto molti tratti di questo antico itinerario sono
rimasti intatti e percorribili non essendo stati interessati se non in
piccola parte da attraversamenti di strade carrabili in terra battuta. Il
paesaggio che gli occhi hanno il piacere di osservare durante tutto il
percorso è unico e indimenticabile. Il mare da un lato, la giacitura dei
monti che si innalzano,si abbracciano a pettine,si scontrano, quasi a picco
separati ora da ampie valli ora da stretti valloni. Ricchezze immateriali
non sfruttate adeguatamente come si dovrebbe. Gli italiani in Libia avevano
il petrolio sotto i piedi e non lo sapevano, e la storia si ripete.
All' Acqua Perara ai nostri giorni
si arriva per mezzo di una strada sterrata che si diparte acanto al nostro
Cimitero. Arrivati,cani scodinzolanti ci aspettano e molto spesso negli
orari giusti s'incontra il pastore Pietro De Luca che accoglie gli
escursionisti con tanta cortesia e, se si è fortunati, si ha l'opportunità
di gustare un piatto di ricotta con il siero.
Per andare a Pagliara e
Roccalumera
Sembrerebbe il percorso più agevole,
ma sicuramente era il più difficile in quanto il suo itinerario utilizzava
l'attuale Via Fabrizi già via Terranova, dove trovasi la Chiesa della
SS:Trinità, da lì si toccava funtanedda (Fontanella) e poi attraverso
stretti sentieri dopo aver superato le difficoltà di Valanca Vecchia si
arrivava a “Cucuzzu” (Cocuzzo). Utilizzando quella stradina ripida posta
sotto il Belvedere, si arrivava al torrente Dinarini e da lì costeggiando si
arrivava a Badia dove trovasi l'antico Monastero basiliano eretto dal Conte
Ruggero nell'anno 1100, torrente di Cosentino permettendo. Fin qui il
tragitto non doveva essere oltremodo difficile. Ma da Badia per andare a
Pagliara seguendo il corso del torrente doveva rappresentare quasi
un'avventura, anche se molti monasteri venivano edificati nei pressi dei
torrenti proprio per poterli utilizzare anche come vie di comunicazione. Il
portone d'ingresso del nostro Monastero è rivolto verso la strada che porta
al vicino torrente.
Impossibile da percorrere nel
periodo invernale a causa del torrente in piena. Su questo percorso si
potrebbe avanzare una ipotesi alternativa, non corroborata da fonti scritte
né da fonti orali, in quanto sembrerebbe la più logica. Arrivati a Badia si
sarebbe potuto utilizzare il fianco sinistro della montagna che si poggia
sul Dinarini non nella posizione dell'attuale provinciale ma più a monte
nella zona di Bottari per poi arrivare a Natticò, già nucleo abitato di
Pagliara, e da lì seguire lo stesso tracciato utilizzato dai Pagghiarini per
raggiungere Pagliara e quindi Roccalumera,ma sono solo supposizioni. Chi ha
certezze documentali o orali potrebbe benissimo darci un aiuto in tal senso.
Questa via di comunicazione per Roccalumera, come si vede, era la più
difficile da percorrere ed è stata la più difficile da posizionare sul
terreno.
Altro aiuto ci potrebbe arrivare
tuffandoci nel lontano passato e approfondendo la zona dei Palaistenoi che
secondo gli atti del Convegno della SISAC (Messina-Reggio Calabria 24-26
maggio 1999) di Bruno Gentili “dovrebbe coincidere con quella di Mandanici,
Locadi, Pagliara lungo l'attuale Dinarini.”
Per andare a Castroreale
Fiumi d'inchiostro sono stati
scritti su questa strada, sia in sedi istituzionali sia su pubblicazioni a
cominciare da quelle del Cav. Luigi Mazzullo,di Domenico Bonvegna,di Aurora
Albert e di Padre Giovanni Parisi.
Per Aurora Albert era la strada
degli eserciti, per Domenico Bonvegna la strada dei pellegrinaggi,per il
Cav. Mazzullo la strada della riscossa che avrebbe garantito sviluppo per
Mandanici nonché la strada utilizzata dal Gran Conte Ruggero per trasportare
la salma del nipote Serlone da Taormina a Gala, per padre Parisi
rappresentava l'antico “stenà” greco e le “fauces” utilizzate da Pompeo nel
36 a.C.
Sembrerebbe strano e paradossale, ma
Mandanici intratteneva ottimi rapporti con le popolazioni del versante
tirreno, rapporti che sono venuti lentamente a mancare con la costruzione
della provinciale Mandanici-Roccalumera alla fine del diciannovesimo secolo.
Attraverso questa mulattiera di
collegamento i Mandanicesi si recavano (e si recano) in pellegrinaggio a
Tindari, i giovani studenti frequentarono le scuole del magistrale di
Castroreale, i Bafioti venivano nelle fiere del SS: Salvatore e di San
Michele a vendere e/o acquistare animali e altri prodotti.
Ogni settimana i genitori dei nostri
studenti attraverso queste montagne impervie li andavano a trovare portando
il necessario per vivere. Tra essi ricordiamo Carmelo Fasti e i fratelli
Peppino e Sebastiano Ricciardi.
Partendo da Mandanici i principali
punti di riferimento che si toccavano e che sono rimasti immutati nei loro
toponimi erano:
Quartiere SS. Salvatore
Firricchio
Carùsu
Pietrafitta o Passo della
Provvidenza
Barréra
Mazzusu
Riotto
Marinara-Brigghiu
Babbuna
Scarrunumoddu
Fossa Lupo, da lì con tornanti
serpeggianti si saliva fino a
Portella fossa lupo (ove trovasi la
pineta detta “e pignara”
Valanca Baddi (Valanca balle)
Rutta Campana (grotta campana)
Puttedda fimmina motta
Puttedda iaddili (portella Gardile)
1.174 slm (chi beveva alla vicina fonte perdeva quasi la voce)
da Jaddili, dove quasi tutti i
Comuni ionici hanno eretto edicole votive dedicate alla Madonna del Tindari,
è possibile vedere in lontananza il Santuario. Si scende quindi verso
ghianu maggi (piano margi)
(territorio del Comune di Castroreale a 900 msl). Da Piano Margi utilizzando
un tragitto più breve è possibile arrivare a Bafia. Ed era questo il
percorso del pellegrinaggio che poi continuava per Rodì fino alla confluenza
con la statale sul ponte di Mazzarà S.Andrea.
Invece per recarsi a Castroreale si
continuava per
Speciale
Valanca fussazza
Puttedda càlamo
Castroreale
I superamenti delle creste erano
denominati “puttedda”, rappresentando essi la porta di accesso e il punto
più basso e agevole di ogni valico. I terreni attraversati erano ora
verdeggianti ora aridi dove solo qualche vecchio pirainaru (pero selvatico)
consentiva di riposarsi e riparasi dai caldi raggi del sole.
Il nuovo Governo unitario, nato nel
1861, ebbe a cuore la costruzione di una via stabile tra i due versanti
ripercorrendo per somme linee il tracciato della millenaria via di
collegamento.